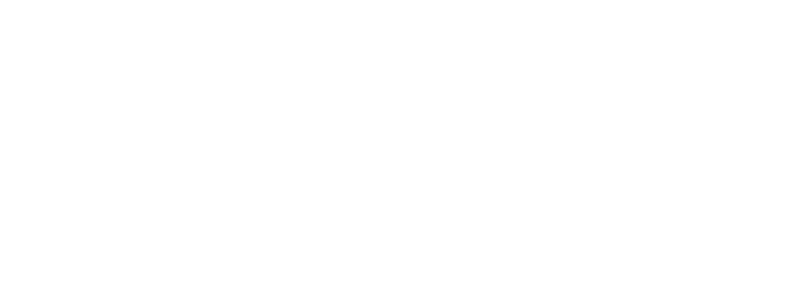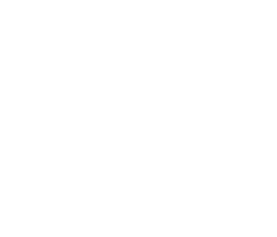La gallina mi ha insegnato che: elogio del senso pratico/1
Cani, gatti, criceti, iguane e… anche galline: è vario e variato il numero degli animali totem in questa nostra modernità liquida.
Gli animali da sempre hanno accompagnato la nostra storia ma in anni recenti si sono evolute le motivazioni per cui li alleviamo: dimmi perché allevi e ti dirò chi sei, potremmo azzardare in un aforisma forse scontato ma non banale.
E se stupisce, fino ad un certo punto, l’attaccamento che riserviamo ai vari Fufi e Micio, che sempre di più chiamiamo con nomi di persona, meraviglia ulteriormente la popolarità della gallina.
Sono sempre di più coloro che vorrebbero elevarla al rango di animale d’affezione, come si dice in italiano o di pet, con quell’inglese che usiamo spesso e a volte a sproposito per nobilitare cose che sarebbero belle e valide di per sé.
La gallina è diventata l’icona starnazzante di un mondo globalizzato, iperconnesso e supertecnologico per una serie di ragioni.
Gli animali nelle varie civiltà sono diventati simboli quando, oltre a se stessi, hanno incarnato simboli oltre.
E cosa ci rappresenta la gallina? Cosa ci insegna?
Una specie di arca, a mio vedere, in cui sono trasportati tanti valori di cui abbiamo nostalgia e che vorremmo portare nelle nostre vite ad alta velocità.
A me personalmente questi pennuti, di cui sono un mediocre ma appassionato allevatore, hanno insegnato tante cose e mi sento di dissentire dalla celebre canzone di Cochi e Renato.
Se la allevassimo solo per le uova, sarebbe più comodo andare al più vicino negozio o supermercato: gli animali per piccoli che siano sono sempre un impegno e un costo, costo al rialzo dato che i cereali, nel caso dei nostri miti bipedi, sono saliti in maniera esponenziale.
Andando in ordine rigorosamente sparso, le galline ci ricordano quel nonno, zio o parente che stava in campagna, ci ricordano quel mondo agricolo che accomuna buona parte di tutti noi: basterebbe sfogliare album di famiglia per trovare immancabilmente la fotografia nella fattoria di nonna Tersilia dove c’era sempre un pollastro sullo sfondo.
Riavvolgendo il nastro di una memoria alla Proust salta poi fuori il pulcino regalatoci da bambini, quelli che volonterose maestre d’asilo ci facevano trovare in un bel mattino di primavera o, vera magia, fatti schiudere a scuola da una piccola incubatrice didattica rimediata chissà dove.
Quando poi quel pulcino cresceva abbiamo sperimentato una cosa fondamentale ovvero il senso della cura: quell’operazione quotidiana del dar da mangiare e bere ad un essere che dipendeva da noi ci ha instillato l’idea che nella vita le emozioni non bastano ma si devono concretizzare in sentimenti e azioni, come appunto l’attenzione e la cura, un amore fatto di rispetto e di gesti.
C’era e c’è poi la gioia e la meraviglia nel raccogliere l’uovo appena fatto, il senso concreto di un impegno in un mondo sempre più virtuale. Negli anziani poi, quelli che hanno visto la guerra, anche un senso di gratitudine: sotto le bombe e con quella miseria della tessera annonaria, quell’ovetto trovato nel nido era la garanzia che si sarebbe mangiato e la speranza in un giorno migliore.
E se quest’uovo, fertile, veniva e viene messo sotto una chioccia o in un’incubatrice l’ansia, l’attesa di una schiusa di un essere fatto e finito, una ventina di giorni che trasformano un qualcosa di apparentemente inerte in nuova vita.